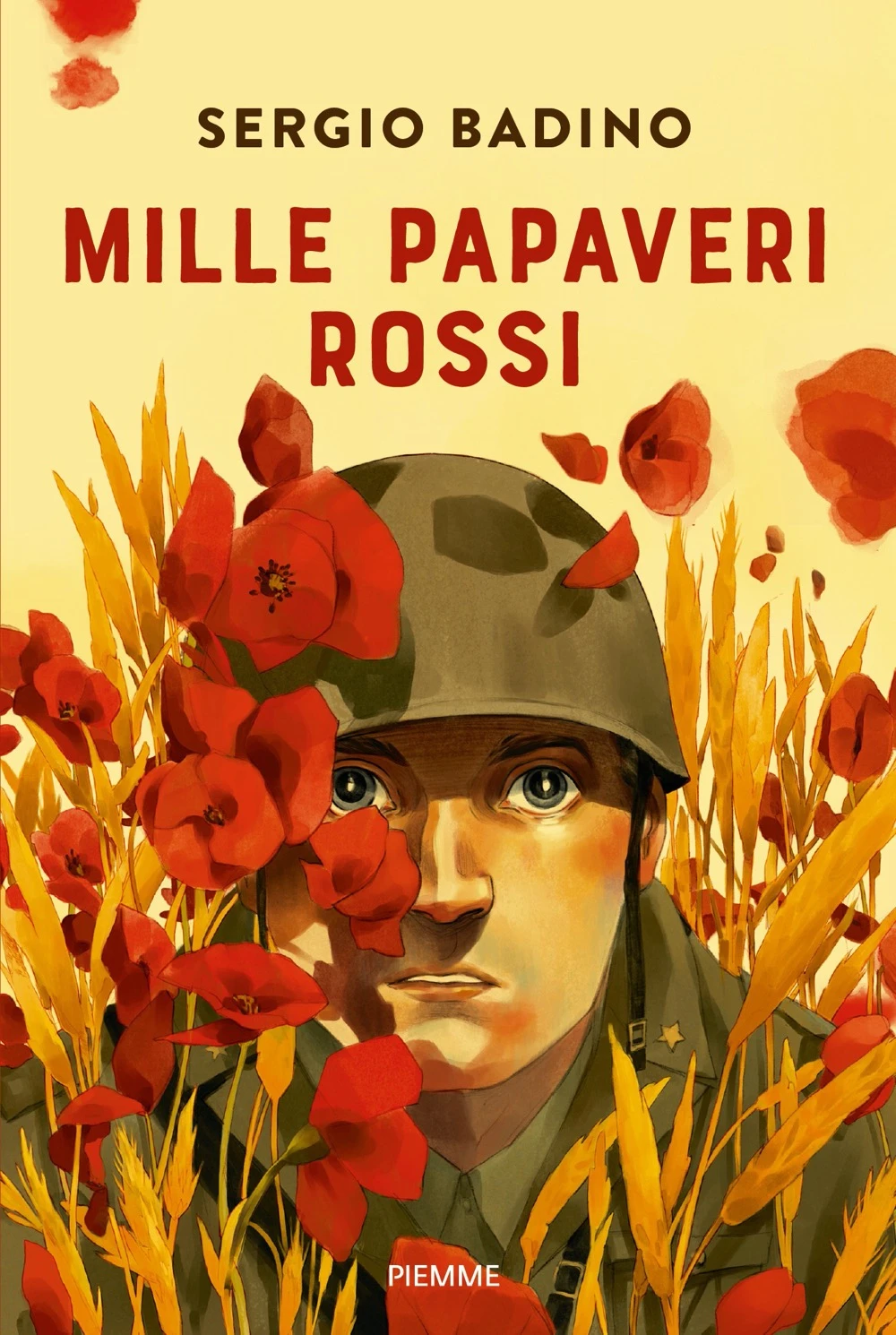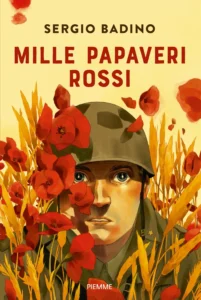Il mio De André
di Sergio Badino
10 gennaio 2024
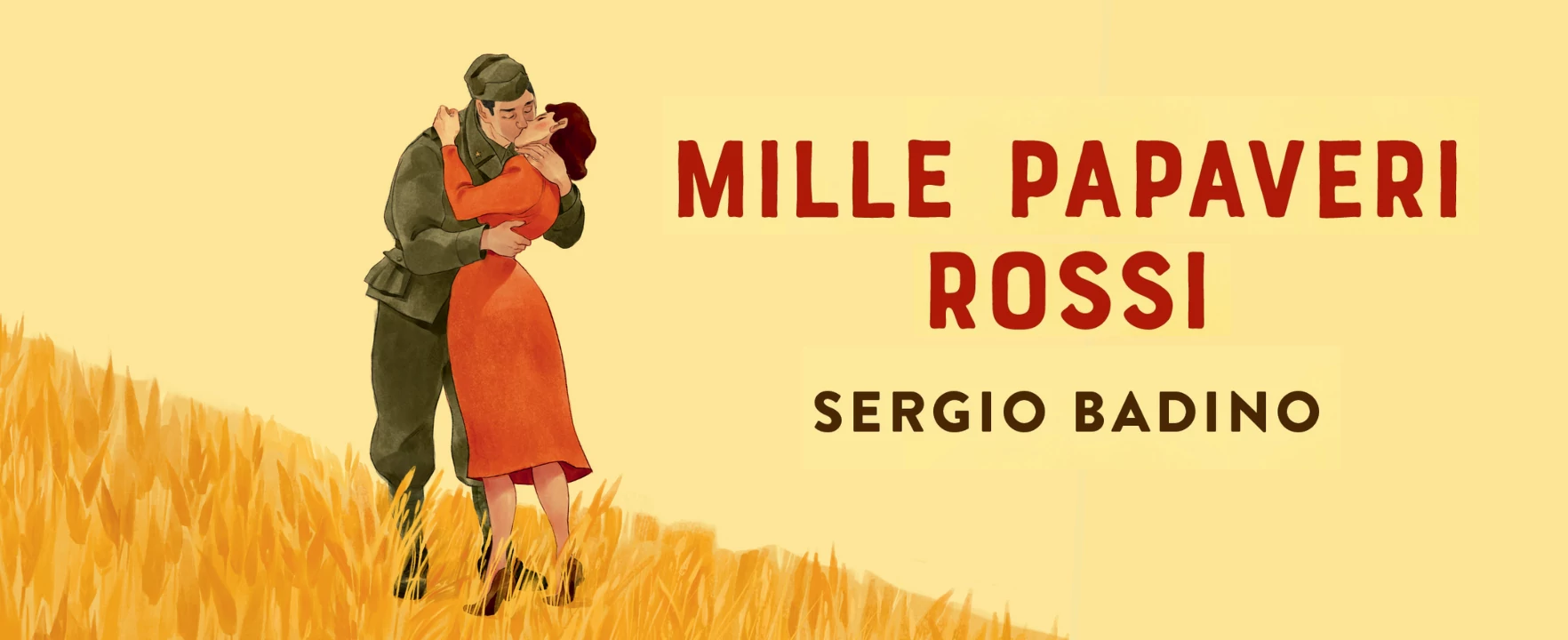
“La colonna sonora della mia vita“. Trovai queste parole scritte a mano su un foglietto in mezzo a un libro con i testi delle canzoni di Fabrizio De André. Il libro era di mio padre, gliel’avevo regalato io e, tempo dopo, me l’ero fatto prestare; la frase chiudeva una serie di appunti di papà sui testi del cantautore.
Suo concittadino e praticamente coetaneo (De André era del 1940, lui del ’39), mio padre condivideva con Faber la forte passione per natura e botanica, ma non la fede calcistica: da sempre tifoso della Sampdoria, non mi parlò mai del fatto che il suo musicista preferito fosse genoano, quasi si trattasse di un grave peccato da dover nascondere o di qualcosa di trascurabile. Tanti pregi e, in fondo, un unico difetto.
Nel momento in cui mi trovai tra le mani quel pezzo di carta e lessi quanto annotato da papà, l’ultima frase mi fece sorridere di tenerezza, ma la trovai lì per lì un po’ ingenua. Colonna sonora di una vita intera, pensai. Addirittura.
Uno dei miei primi ricordi musicali riguarda proprio Fabrizio: sono a casa, con mia madre, ho cinque o sei anni e il mangiacassette diffonde note che non scorderò più. L’album è L’indiano – che in realtà non
s’intitola così, ma solo Fabrizio De André; è chiamato in quel modo per l’immagine in copertina – e due
brani dal ritmo incalzante mi conquistano con una combinazione ipnotica di voce e parole: il calipso di
Franziska e il reggae di Verdi Pascoli.
Il disco è uscito da circa quattro anni e, a quell’epoca – i primi anni Ottanta – i miei genitori sono già separati. L’album successivo, Crêuza de mä, del 1984, non entrerà mai in casa (lo comprerò io in CD, anni dopo), credo perché interamente in dialetto genovese, che mio padre parlava come una seconda lingua, e forse mia madre non si sentiva di ascoltare qualcosa che la riconducesse a lui in modo così diretto.
Quando escono i due dischi successivi, gli ultimi, io sono già più grande: dodici anni con Le Nuvole (1991) e diciassette con Anime Salve (1996). Si tratta degli album di De André cui sono più legato, forse perché li ho “vissuti” maggiormente, con consapevolezza. Vi sono passato in mezzo.
All’epoca di Le Nuvole i miei si frequentavano comunque, facevamo spesso gite insieme, e l’album monopolizzava l’autoradio. Papà annotava con scrupolo sul booklet della musicassetta i termini in genovese che non conosceva e sottolineava i passaggi dei brani che desiderava approfondire: ricordo intense conversazioni con alcuni suoi amici sul significato di La domenica delle salme.
Nel ’96 acquistai io Anime Salve per mia madre e ne feci una copia per mio padre; quanti frammenti, strofe, frasi delle canzoni di De André sono entrati negli anni nel frasario di papà, in una sorta di lessico famigliare che conivolse anche me. Cáu oú mè zuenótto, caro il mio giovanotto, mi chiamava spesso papà citando un passaggio di  cúmba.
Ascoltare De André mi riporta alla mia famiglia, ma anche alla scuola: il Liceo Classico Colombo di Genova, in cui ho trascorso cinque indimenticabili anni, è lo stesso che frequentò Faber e, quel 13 gennaio del ’99, fui scelto insieme ad altri studenti (da anni mi occupavo del giornale scolastico) in rappresentanza dell’istituto per presenziare al funerale.
Gli anni che seguirono li dedicai ad approfondire il De André che conoscevo meno, quello dei primi tempi, e
recuperai a ritroso tutti gli album antecedenti la mia nascita.
La colonna sonora della mia vita. Oggi, a venticinque anni dalla morte di Fabrizio (per me come uno di famiglia), non ho dubbi a definirne l’opera nello stesso modo scelto da mio padre. De André è compagno
di viaggio, stile di vita, guida che indica il percorso. Linguaggio che mette radici. Oggi come allora lo
ascolto a casa e in auto; i miei bambini prediligono magari i brani più orecchiabili, ma uno dei primi pezzi
che Bianca ha imparato a strimpellare al piano è proprio La guerra di Piero. Sensibilità, poesia,
attenzione per gli altri, per i più umili: è questo il De André che resta dentro.
Gian Carlo, mio papà, è mancato nel 2021: in uno degli ultimi giorni, quando la malattia gli impediva perfino di parlare, i suoi occhi si spalancarono per la gioia e il volto si distese in un sorriso nel momento in cui gli feci ascoltare Crêuza de mä per l’ultima volta. Tempo dopo ho saputo che per anni, ogni giorno, aveva offerto il pranzo a una famiglia bisognosa, invitandoli a casa sua, senza mai farne parola con nessuno.
Sergio Badino