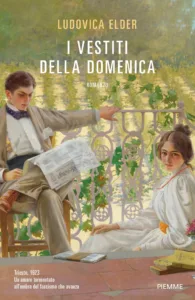Intervista a Ludovica Elder, autrice de I vestiti della domenica
di Redazione Web
7 aprile 2025
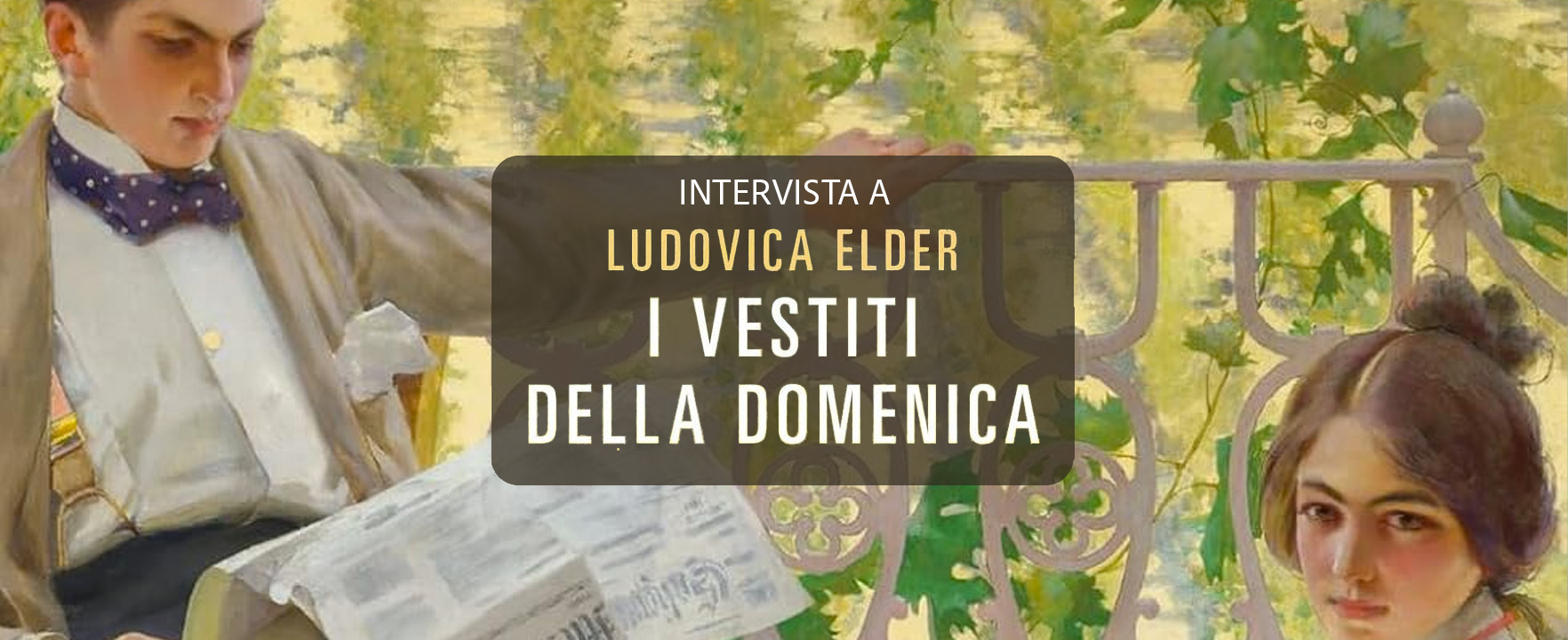
I protagonisti, Vittorio e Antonia, sono figli di due grandi famiglie: gli Stefàncich, signori dei traporti del Litorale, e i Pàhor, proprietari di una grande vigna sul Carso. Chi sono?
Vittorio è un uomo tenace, deciso, che conosce la responsabilità. Ha fatto la Grande Guerra scegliendo da che parte stare, disertando dall’esercito dell’imperatore e schierandosi con l’Italia: è un uomo fermo e ambizioso. Antonia è una ragazza del Carso, ma che ha studiato in città. È stata affascinata dalla dolcezza effimera del bel mondo, ma capisce di appartenere a una realtà diversa, di essere legata alla sua terra e di amare le sue tradizioni. In questa apparente perfezione, anche loro, come tutti, hanno debolezze, sbagliano, inciampano e si rialzano. Anche se non sempre tutto è come sembra.
Questo romanzo parla di un grande amore, quello tra Vittorio e Antonia, ma c’è un altro personaggio che, più di tutti, interpreta lo spirito del tempo. È Giacomo, figlio di un prestigioso avvocato, affascinato dalla grandiosità del sogno fascista. Un personaggio arrogante, ambizioso, furbo e debole al tempo stesso. Difettoso e umano. Quale sarà il suo destino?
Giacomo risponde alla propaganda dei primi Fasci con l’ardore che ci si sarebbe aspettati da un ex combattente deluso. Invece lui non ha fatto la Guerra, è stato un imboscato. Eppure vuole trovare un modo per affermarsi, per uscire dal cono d’ombra dell’ingombrante padre. E sceglie il suo destino, per una volta da solo, facendosi trascinare dall’euforia della folla e dalla forza della sua frustrazione.
Perché hai scelto di ambientare il tuo romanzo tra Trieste e il Carso?
Sono posti molto belli. Sono lontani da tutto, e forse porprio questa è una delle ragioni del loro fascino. Trieste è sempre stata una città di confine: lo era quando rappresentava il porto franco di Vienna e dell’Impero austro ungarico, lo è rimasta quando la sua capitale è diventata Roma. Penso che la misticanza di gente, di lingue, di religioni, di commerci, di idee siano sempre stati i punti forti e non le debolezze di questa città. Le differenze tra le lingue e le culture, però, sono diventate anche motivi di odio. E proprio sull’appartenenza linguistica e culturale ha giocato la propaganda per scatenare il fascismo di confine, battezzandolo col fuoco del Balkan, descritto a parole da Boris Pahor e a colori da Vito Timmel.
Sei mai stato a Trieste? Le persone in dialetto si chiamano “i matti”, il caffé si beve nel bicchiere, la bora aiuta a non prendersi troppo sul serio!
Il Carso, invece, osserva tutto dall’alto, in silenzio, sornione. L’altopiano non è solo quello di Ungaretti, in cui la Grande Guerra ha lasciato brandelli di muri. È straordinariamente affascinante quando d’autunno si colora con le foglie rosse del sommaco, è un punto di visione esclusivo quando si vuole guardare il mare. È un luogo di ritrovo genuino quando si visitano le osmize, quei posti dove si mangia roba semplice, si spegne il telefono e si accende il cuore.
Chi si mette e chi si toglie I vestiti della domenica?
I vestiti della domenica sono quelli buoni, da usare nelle occasioni speciali. Per Antonia, Vittorio e Giacomo, grazie alla loro condizione privilegiata, è sempre domenica. Loro si affacciano sul mondo nuovo: è cambiata la nazione alla quale appartengono – ora sono italiani – cambiano le aspettative, le speranze, gli obiettivi. Ma rimangono dei fortunati. Rosalba, invece, deve togliere il suo vestito della domenica, una volta a casa, quando finisce la festa. Guai a rovinarlo! È una cameriera, e guarda alle vite degli altri con risentimento e malinconia. C’è un quadro di Egon Schiele, l’allievo di Klimt, che raffigura una “Donna con il ginocchio piegato”. Quando penso a Rosalba vedo quel viso con lo sguardo fiero e un po’ arrabbiato di chi, alla fine, non si arrende.
Qual è il personaggio che senti più vicino, il tuo preferito?
Forse dovrei dire Antonia e Vittorio, che sono “i buoni”. E invece penso a Giacomo, senza dubbi. Quando ho visto per la prima volta l’autoritratto di profilo di Joaquin Sorolla, quello con la giacca beige, ho pensato che fosse proprio quello il viso di Giacomo Ledri. Lui è il mio preferito perché è un cattivo disperato, alla ricerca di sé stesso. È anche una persona colta, con una dimenticata dolcezza; ignora e nasconde le parti migliori di sé, credendo sempre di non essere abbastanza, scegliendo l’arroganza per nascondere l’infelicità. Penso ci sia un po’ di Giacomo in tutti. Io, per lo meno, ce l’ho.
L’amore vince sempre? E l’odio?
Non lo so se l’amore vince sempre, ma certamente vale il tentativo. Antonia e Vittorio si muovono dentro al sentimento, minato dalle incomprensioni e dagli errori. Loro rappresentano la consapevolezza, il tentativo di trovare un punto fermo che rappresenti un approdo. L’odio è capace a volte di solleticare furbizie e di stimolare strategie. Ma regala soddisfazioni momentanee, che crollano con la stessa facilità con cui si sono costruite. Non vorrai mica che racconti il finale del romanzo, vero?
Chi è Ludovica Elder?
Sono molto legata alla terra da cui provengo, anche se ci vivo lontana da molti anni. Ci sono stati momenti in cui ho sentito il bisogno di allontanarmi, anche io come Giacomo, alla ricerca della mia strada. Ma penso che il fulcro attorno a cui girano le nostre vite resti sempre il posto in cui siamo nati. Fa parte della nostra storia.
In questo libro ho parlato di quello che conosco da sempre. Ci sono gli odori della cucina della mia nonna, quando nella casa in campagna in fondo alla Stradella Verde (che esiste davvero!) preparava gli gnocchi con la marmellata di prugne. “Di susini”, come diciamo noi. Ci sono i colori del Carso, il rumore della Bora, l’asprezza del vino terrano (un vino poco elegante, ma buonissimo, molto scuro, da tanto è carico di vita e di sole del Carso). Tutte cose che si possono sperimentare.
Quali sono i tuoi autori preferiti?
Mi piace moltissimo la scrittura di Paolo Rumiz, di Antonio Scurati, di Orhan Pamuk, di Ian McEwan. Sedimentate dentro di me ci sono le letture di Stefan Zweig, di Sándor Márai, di Svevo e il mai superato teatro di Pirandello. E siccome amo la Sicilia, cito anche Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Simonetta Agnello Hornby.